 Regia – Sandor Stern (1988)
Regia – Sandor Stern (1988)
Pin è un film bellissimo, e forse non ha poi questo gran diritto di cittadinanza in una rassegna di filmacci estivi, solo che mi è stato espressamente richiesto da un amico e io non dico mai di no a chi se ne esce con questi gioielli che conosceremmo in sei; inoltre, se non ne parlo in questo contesto, va a finire che non ne parlo più. Sfruttiamo l’occasione per diffondere il verbo dell’ennesimo grande horror canadese che capita su queste pagine. Di canuxploitation e di Tax Shelter abbiamo già discusso abbastanza di recente, quindi non sto a ripetermi, ma se volete conoscere la complessa e interessantissima storia del cinema di genere prodotto in Canada, c’è un documentario disponibile su Youtube che vi consiglio di vedere.
Pin arriva un po’ tardi per beneficiare del Tax Shelter, ma ormai, alla fine degli anni ’80, il cinema indipendente canadese, in particolar modo l’horror, non aveva nulla da invidiare a quello statunitense.
Sandor Stern, oltre a essere stato, una decina di anni prima l’uscita di Pin, lo sceneggiatore di Amityville Horror, era un regista televisivo, e sarebbe rimasto tale per tutto il resto della sua carriera. Pin non è soltanto un esordio, ma un episodio unico. Dispiace, perché si tratta di un’opera di grandi sensibilità e raffinatezza, un horror psicologico che, pur avendo qualche debituccio nei confronti del solito Psycho, è forse tra i più originali e profondi nel filone “pupazzi assassini”. E anche a inserirlo del tutto nel filone, gli si fa un grande torto.

Pin (abbreviazione di Pinocchio) è un manichino anatomico a grandezza naturale, usato dal dottor Linden (Terry O’Quinn) per spiegare ai suoi due figli, Leon e Ursula, come funziona il corpo umano. Grazie alla sua abilità di ventriloquo, Linden fa “parlare” Pin direttamente con i due ragazzi, e anche con altri giovani pazienti, per metterli a loro agio durante le visite.
Se Ursula sin da bambina sa distinguere tra realtà e finzione, Leon cresce convinto che Pin sia vero. Essendo un ragazzo timido e riservato, con una figura materna molto rigida e un padre distaccato, il cui unico mezzo per mostrare affetto è appunto un pupazzo, Leon crede che Pin sia suo amico, il solo, e continua a crederlo anche da adulto.
I genitori di Ursula e Leon muoiono in un incidente d’auto e i ragazzi ereditano la villa di famiglia. Ursula trova un lavoro in una biblioteca, conosce un ragazzo e se innamora, mentre Leon prosegue con la sua vita da recluso, porta a casa Pin, lo veste come il padre, lo trucca come un essere umano e, di fronte a una sempre più preoccupata Ursula, scivola ogni giorno di più nella follia.
Pin è un film che si insinua sotto la pelle: non c’è una goccia di sangue, non ci sono jump scares, se ne sta sempre in bilico sul confine tra horror soprannaturale e dramma della solitudine, è, a suo modo, elegante nel suggerire gli elementi più scabrosi senza scadere nel sensazionalismo, ma quando si tratta di traumatizzare il pubblico, e insieme a lui il piccolo Leon, non si pone il problema di mostrare Pin usato da un’infermiera come giocattolo erotico, in una delle scene più allucinanti e audaci del cinema horror anni ’80; Pin, a differenza di molte pellicole dell’exploitation (canadese, statunitense, australiana, poco importa la nazionalità), non basa la sua efficacia sull’eccesso, ma sulla misura. Se si esclude quell’unica sequenza già nominata, tutto il resto del film è un ambiguo gioco di recitazione, scrittura dei dialoghi, con una regia estremamente classica e posata, direi quasi invisibile e del tutto dedita al racconto.

Difficile definire cosa sia Pin con esattezza: come ho detto prima, inserirlo nel campo dei pupazzi assassini è una forzatura, perché il manichino anatomico non possiede, in teoria, un’esistenza autonoma. La chiave della riuscita del film sta infatti nel non specificare mai la sua vera natura. È possibile che, in qualche modo, l’atto sessuale con l’infermiera lo abbia attivato, o forse ha solo scatenato la sessuofobia e il terrore del contatto fisico di Leon, che su Pin proietta le sue paure e i suoi desideri; e l’incidente che causa la morte dei genitori di Ursula e Leon può essere stato colpa di Pin, che non voleva essere portato via dal suo amico, o solo frutto di una distrazione del dottor Linden. Non ci sono risposte chiare e sta allo spettatore decidere se credere all’ipotesi soprannaturale, in un certo senso rassicurante, o scegliere invece quella della malattia mentale, che ci porta inevitabilmente in un baratro di squallore e disperazione.
Molto fa l’interpretazione di David Hewlett, qui giovanissimo e a una delle sue prime apparizioni su grande schermo: il suo Leon comunica disagio solo con la postura del corpo, sempre un po’ inclinato in avanti, nervoso, sul punto di scattare. Hewlett evita di abusare dei cliché che di solito definiscono un personaggio mentalmente instabile e, al contrario, sceglie una recitazione trattenuta e, per questo, ancora più inquietante, perché con Leon si finisce per empatizzare, si arriva a provare nei suoi confronti un sincero dispiacere e quasi ci convinciamo insieme a lui che Pin abbia un’anima, una qualche forma di intelligenza: se così fosse, Leon sarebbe meno solo.
A tentare di porre un’argine a questa follia c’è la povera Ursula (Cynthia Preston), presa in trappola tra l’affetto nei confronti del fratello maggiore, cui è legatissima, la consapevolezza che in lui ci sia qualcosa che non va e la sua personale aspirazione a una vita normale, fuori da quella tetra villa, lontana da Pin, dai cimeli di famiglia e da un rapporto che spesso prende quasi le sfumature di una relazione incestuosa.

C’è un tale campionario di devianze e perversioni in Pin che basterebbe per cinque film; alla fine ci sente schiacciati da un peso di angoscia e ti restano anche addosso un paio di cicatrici, perché Pin non è semplicemente la storia di uno psicopatico che si nasconde dietro a un pupazzo per commettere indisturbato i suoi omicidi, e neanche la storia di un pupazzo posseduto o animato da intenzioni malevole; Pin è la storia di un bambino e poi di un giovane uomo talmente isolato dal resto del mondo (la madre gli proibisce di frequentare i suoi coetanei perché sporcano) da scegliere di creare una realtà alternativa; è la storia di una sorella che, vuoi a causa di un carattere più estroverso, vuoi perché ha assorbito meno l’atmosfera di repressione che si respirava in famiglia, vorrebbe solo cominciare a vivere come gli altri e invece rinuncia per proteggere suo fratello e non farlo finire in un istituto, con conseguenze tragiche; è la storia di un’infanzia negata e di un’adolescenza non vissuta. E Pin è soltanto una presenza, certo minacciosa, che si fa carico di un disagio terribilmente reale.
Uno degli horror più interessanti e atipici degli anni ’80, e anche uno dei meno famosi. È arrivato il momento di prestargli un po’ di attenzione.









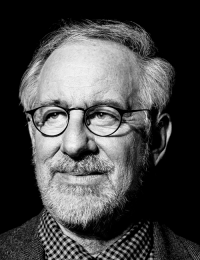






questo non solo lo conosco, ma lo adoro! 😀 il perché lo hai descritto perfettamente nella tua splendida recensione, quindi non sto a ripeterlo. aggiungo solo una cosa: ma quanto è inquietante/geniale il finale? 😀
davvero una piccola gemma da riscoprire!
E quanto è triste, oltre che inquietante:
“Hai avuto più notizie di Leon?”
“No”
“Mi manca, lo sai?”
“Anche a me”
E giù a singhiozzare 😀
Non ne avevo mai sentito parlare, lo cercherò
Se l’amico di cui parli all’inizio del post sono io grazie in primis per avermi definito così (di rimando, sorella, col cuore).
La prima volta lo vidi su La7 un pomeriggio, ero ragazzo e mi intrippai eccessivamente sull’occulto (forse perché a quell’età avevo più dense of wonder e certe cose preferivo interpretarle di conseguenza); credo però di averlo amato completamente alla seconda visione qualche mese fa, perché ho usato la chiave di lettura della malattia mentale che tu enuclei benissimo e che tinge di tragedia un horror psicologico che a parte qualche difettuccio è pressoché perfetto nel suo bilanciare gli aspetti e le tematiche della storia.
È come le belle donne, quelle che ti restano in testa sul serio: gli basta dire e non dire, far intendere, vedo e non vedo.
E poi il finale è una coltellata, siccome lo hai nominato, per me può piazzarsi comodamente alle spalle del frame finale di Psycho.
Eh sì, l’amico sei proprio tu!
Ma lo sai che capitò anche a me di vederlo su La7? Perché proprio non lo avevo mai sentito nominare e non avevo idea che esistesse. Ero già più grandicella, ma fu una discreta mazzata.
E rivederlo è stato molto istruttivo, diciamo, con la consapevolezza acquisita nel corso degli anni, capisci tante cose a cui prima non arrivavi.
Ti ringrazio per avermici fatto pensare!
Sì, temo proprio che sia uno dei meno famosi pure per il sottoscritto perché non ricordo di averlo mai visto (in caso contrario, un film di questo livello mi sarebbe stato impossibile dimenticarlo)… quindi è arrivato il momento che gli presti attenzione 😉
Sai che dovrebbe essere su Youtube addirittura doppiato? Il titolo italiano è Chi c’è in fondo a quella scala!
Sì, l’ho trovato (grazie della dritta)! 😉